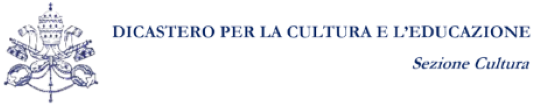Per una Teologia della corredenzione fedele al primato di Cristo
Risposta alla controrisposta di Luisella Scrosati [PDF]
di +Antonio Staglianò
(Presidente della Pontificia Accademia di Teologia)
La cortese ma ferma replica di Luisella Scrosati offre l’opportunità di approfondire ulteriormente le ragioni teologiche che stanno alla base della posizione della Nota dottrinale Mater populi fidelis. Alla luce del dibattito e della prospettiva di un “Illuminismo cristico” – che cerca di purificare la fede da sovrastrutture concettuali per ritornare alla luce rivelata del mistero di Cristo – le obiezioni della Scrosati, sebbene radicate in una tradizione teologica rispettabile, rivelano alcune criticità fondamentali da evidenziare.
1. Il Principio cristocentrico e il “rischio” della fede
Scrosati sostiene che la Chiesa ha sempre accettato il "rischio" di termini potenzialmente equivoci, come "Theotókos" (Madre di Dio), per affermare una verità più grande. Tuttavia, questo argomento non regge fino in fondo. Il titolo "Theotókos" fu difeso esattamente per salvaguardare la verità cristologica sull'unicità della persona di Cristo contro Nestorio. Il suo scopo era chiarire, non moltiplicare i mediatori.
Il "rischio" che la Chiesa non può e non deve accettare è quello di offuscare la sovrabbondante sufficienza dell'opera di Cristo, unico Mediatore (1 Tm 2,5). Mentre "Theotókos" chiarisce chi è Cristo, "Corredentrice", nel suo significato semantico più immediato ("colei che redime insieme"), rischia di introdurre un principio di duplicità nell'atto redentivo, che è invece unico e proprio di Cristo. L’intento della Nota non è una "cassazione" fine a sé stessa, ma un atto di purificazione semantica proprio per proteggere il nucleo della fede. Spiegare un termine è doveroso, ma quando il termine stesso, nella sua struttura, suggerisce un'equiparazione funzionale che la fede non può ammettere, la prudenza magisteriale diventa necessaria.
2. L’“Ordine ipostatico di Maria”: una categoria teologica problematica
Il cuore della controrisposta della Scrosati ruota attorno all’appartenenza di Maria a un "ordine ipostatico". Sebbene ella neghi che ciò crei una "natura ibrida", l’affermazione che questo ordine sia superiore all'ordine della natura, della grazia e della gloria, pone serie difficoltà teologiche. Ne annoto appena due:
La prima è la confusione tra relazione e sostanza. L’unione ipostatica in Cristo è ontologica e sostanziale: il Verbo assume una natura umana. La relazione di Maria con il Verbo è, per sua stessa ammissione, una relazione materna. Per quanto unica e sublime, questa è una relazione personale e creaturale, non un'identità di essere. Parlare di un "ordine" comune a Cristo e a Maria, sebbene a "titolo diverso", rischia di appiattire la differenza abissale tra l’unione ipostatica (propria di Cristo) e una relazione (propria di Maria, seppur la più elevata). Si ha, dunque, tutta la ragione a vedere qui il pericolo di un tertium genus, uno status ontologico intermedio che la dottrina cattolica non conosce.
La seconda riguarda la grazia, che non è un “Ordine Ipostatico”, ma è la Elevazione di Maria. L’elezione unica di Maria è pienamente spiegabile – e anzi, risplende maggiormente – attraverso la dottrina della grazia santificante. L'Immacolata Concezione e la pienezza di grazia la rendono la creatura più eccelsa, la "Tutta Santa", senza bisogno di postulare un "ordine" metafisico separato. La grazia, come partecipazione alla natura divina (2 Pt 1,4), eleva l'essere creaturale senza annullarlo, portandolo alla sua massima fioritura. È questa "umanità divinizzata" – non una "natura ibrida" o un "ordine ipostatico" – il vero miracolo di Maria. Ho sottolineato nella mia Replica come l'espressione "più che creatura" di Dante è un'iperbole poetica che indica il vertice della creaturalità redenta, non la sua uscita dall'alveo creaturale.
3. La purificazione del linguaggio teologico
La via maestra dunque non è né "cassare" acriticamente né aggrapparsi a terminologie divenute problematiche. La via maestra è un ritorno coraggioso al primato assoluto di Gesù Cristo, unico Redentore. È l'umile riconoscimento che la teologia, in quanto esercizio critico della ragione illuminata dalla fede, deve a volte purificare il linguaggio per servire meglio la verità. L’"era glaciale" che Scrosati denuncia è, in realtà, un necessario e salutare disgelo da quelle sovrastrutture dottrinali che, con la pretesa di esaltare Maria, rischiano di offuscare la luce sovrabbondante del suo Figlio e unico Signore.
Pertanto sulla scia di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI è importante, anzitutto, superare una visione puramente giuridica della Redenzione: la Croce non è primariamente la soddisfazione di un debito, ma l’atto d’amore trinitario che trasforma il mondo dal di dentro. Il ruolo di Maria allor non è quello di "co-offrire una soddisfazione" in senso quantitativo, ma di essere il prototipo della creatura redenta che, nella fede, accoglie e coopera liberamente all'amore salvifico di Dio. La sua cooperazione è massima, ma è quella di una credente, non di una "quasi-redentrice". Poi, è decisivo privilegiare un linguaggio biblico ed esistenziale: l’"allergia" non è a Maria, ma a un linguaggio tardo-scolastico che, con categorie come "ordine ipostatico", rischia di reificare il mistero e di creare dispute metafisiche che allontanano dalla semplicità del Vangelo. Il magistero di Benedetto XVI e l'approccio della Nota preferiscono titoli scritturistici come "donna", "madre", "discepola", "collaboratrice", che esprimono in modo più esistenziale e pastoralmente efficace la relazione unica di Maria con il Salvatore. Infine, occorre riaffermare la sofferenza come atto d’Amore e non come “valuta di scambio”: il dolore di Maria sul Calvario ha un valore immenso non perché provenga da una creatura di un "ordine superiore" con un "valore quasi-infinito", ma perché è l’atto d’amore più puro di una creatura, perfettamente unita alla volontà del Padre e al sacrificio del Figlio. Il suo valore non è "quantitativo" (come in una transazione giuridica), ma "qualitativo": è la pienezza della fede e dell’obbedienza. È questa la "cooperazione unica e singolare" che la Nota vuole proteggere da interpretazioni fuorvianti.
In definitiva, la posizione cristocentrica della Nota non è un impoverimento, ma un approfondimento della mariologia: un invito a contemplare Maria non in uno status ontologico ambiguo, ma nel suo ruolo più vero e più grande – la creatura redenta per eccellenza, che brilla della pura luce riflessa di Cristo, l’unica Luce del mondo.
Il punto non è che la "dissimilitudo minor" sia un concetto in sé errato, ma che il suo utilizzo da parte della Scrosati avviene in un modo che frantuma l'unità dialettica dell'analogia, rendendola equivoca e portando alle conseguenze ontologiche problematiche che ho focalizzato nella mia Replica e che riprendo volentieri per meglio approfondire in un dialogo “onesto” e rispettoso.
4. L' Analogia ribaltata: dissimilitudo e similitudo in tensione dinamica
L'analogia entis (analogia dell'essere) classica, in una prospettiva cristiana, non è un semplice proporre somiglianze. È sempre abitata da una tensione insuperabile: la somiglianza (similitudo) con il Creatore è sempre e per sempre fondata su una differenza infinita (dissimilitudo). Più si conosce Dio, più si scopre il suo essere Altro.
L'Analogia ribaltata (sviluppata da pensatori come Hans Urs von Balthasar, ispirandosi a Proclo e Pseudo-Dionigi, e centrale nell'Illuminismo cristico di Ratzinger) porta questo all'estremo. Nella rivelazione cristiana, e specialmente nel Mistero Pasquale, questa tensione non si risolve, ma esplode in un paradosso: la massima rivelazione di Dio (la sua similitudo) avviene nel luogo della sua massima dissomiglianza (la Croce). Il volto di Dio si svela nell'umano sfigurato di Cristo. Qui, dissimilitudo e similitudo non sono due "pezzi" separabili, ma i due poli di un'unica, dinamica e sorprendente verità.
In questa luce, la dissimilitudo (la differenza abissale Creatore-creatura) non è un ostacolo alla similitudo, ma ne è la condizione di possibilità. La similitudo non è mai una "somiglianza" paritaria, ma è sempre una similitudo sempre maior — una somiglianza che, proprio mentre si realizza, scopre di essere fondata su una differenza sempre più grande.
La Scrosati, nel suo argomentare, spezza questa unità dialettica. Lei, di fatto, opera una "quantificazione" della dissomiglianza: a. nella dissimilitudo maior vede la differenza infinita tra Dio e ogni creatura (inclusa Maria). E questo è corretto; nella dissimilitudo minor vede una differenza "minore", ma pur sempre ontologica, tra Maria e tutte le altre creature. E qui sorge l'equivoco.
Per applicare correttamente l'analogia ribaltata a Maria, si dovrebbe dire: la sua unica e immensa similitudo con Dio (la sua piena conformità a Cristo, la sua "divinizzazione" per grazia) brilla proprio in virtù della sua radicale dissimilitudo — il suo essere "umile ancella", la pura creatura che dice "sì". La sua grandezza non sta nonostante la sua creaturalità, ma in e attraverso la sua creaturalità perfettamente redenta e trasfigurata.
La Scrosati, invece, usando la dissimilitudo minor come un gradino ontologico intermedio, sottrae Maria dall'alveo della dissimilitudo maior comune a tutte le creature. Invece di vedere la sua incomparabile similitudo come il frutto mirabile della grazia che opera all'interno della condizione creaturale, la colloca in uno status ontologico diverso.
Questo "spezzatamento" ha un effetto devastante sulla comprensione di Maria: nella prospettiva della Analogia ribaltata Maria è il capolavoro della grazia. La sua similitudo con Dio è massima proprio perché la grazia ha portato la sua natura creaturale al suo compimento più sublime, senza uscire dai suoi binari. La dissimilitudo con Dio rimane infinita, ma in lei questa distanza è colmata dall'Amore divino in modo così totale da farla risplendere come "piena di grazia". La similitudo è "sempre maior" perché fondata sulla dissimilitudo. Nella prospettiva della Scrosati, la grandezza di Maria non deriva più primariamente dall'azione della grazia in lei come creatura, ma dal suo possedere uno status ontologico speciale (l'"ordine ipostatico"). La sua similitudo con Dio rischia così di non essere più "sempre maior" (cioè fondata sulla differenza), ma di diventare una somiglianza "di un altro tipo", basata su una presunta "natura ibrida" o su una vicinanza ontologica privilegiata. Indebolisce la dissimilitudo per garantire la similitudo.
Conclusione: Dialettica e Opposizione polare?
Nell'Analogia ribaltata, dissimilitudo e similitudo si giocano in un'opposizione polare (R. Guardini) dove due termini si fronteggiano come contrari, ma dialetticamente. Sono una coppia dinamica e inscindibile, come il respiro: l'inspirazione e l'espirazione. La dissimilitudo è il "vuoto" che permette all' "aria" della similitudo di riempire i polmoni. L'una non esiste senza l'altra, e la loro tensione è feconda.
La Scrosati, giocando con il concetto di dissimilitudo minor, trasforma questa dialettica vivente in una gerarchia statica di "ordini" ontologici. In questo modo, non coglie adeguatamente la vera similitudo di Maria, che è tutta giocata all'interno del mistero della Grazia che trasfigura la Creatura, senza bisogno di uscire dall'orizzonte della dissimilitudo maior che ci unisce tutti, Maria compresa, nell'umile e glorioso stato di figli redenti da un Unico Salvatore.
Antonio Staglianò