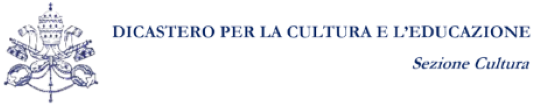IO SONO COLUI CHE SONO
Dio disse a Mosè: Io sono colui che sono! Così dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi! (Esodo 3,14)
Nella vastità solitaria del deserto, ecco accendersi una fiamma: da un rovo che arde si leva una voce misteriosa che interpella quel viandante spossato. Tutti hanno inciso nella fantasia questa scena che ha anche conquistato la storia dell’arte: Mosè fuggiasco dall’Egitto riceve al Sinai la vocazione che lo impegnerà in un’ardua missione, quella della liberazione del suo popolo dall’oppressione faraonica. Là, in quel momento capitale della storia, Dio si rivela con una frase enigmatica: essa sembra una definizione, ma è anche un’espressione indecifrabile, è la rivelazione di un nome, ma ne è anche quasi una negazione, nella consapevolezza, tipica di quella cultura, che possedere il nome di una persona o di una cosa è dominarla. E Dio non può essere sottomesso, imprigionato e manipolato.
Ecco, allora, davanti a noi quella formula che nell’originale ebraico suona così: ’ehyeh ’asher ’ehyeh, «Io sono colui che sono», formula abbreviata nel semplice “Io-Sono”. In questa misteriosa denominazione si è appuntata da secoli l’analisi di semplici lettori e di grandi teologi. Certo è che al centro si ha il verbo “essere” che potrebbe presentare Dio come l’Esistente per eccellenza (più che l’Essere in senso filosofico, come si usava proporre nel pensiero occidentale). Egli è il Vivente, l’Immortale, l’Io supremo, trascendente e misterioso, perfetto, eterno e infinito.
In questa luce sembra quasi che Dio si rinchiuda nella sua sublimità di “Colui che è”. In realtà, questa designazione non è una fredda definizione teologica che relega Dio nel suo orizzonte superiore, remoto dal nostro. Infatti, subito dopo egli aggiunge: «Io-Sono mi ha mandato a voi… Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi» per liberarvi (Esodo 3, 14-15). Non è, dunque, un imperatore divino impassibile o indecifrabile come il Fato greco. Egli ha scelto di rivelarsi ai padri di Israele, entrando quindi nella storia umana, e ora sta per essere alle spalle di Mosè in una missione a prima vista impossibile.
Certo, un Dio misterioso e non riducibile a una componente della realtà, “Io-Sono” in tutta la grandezza della divinità; ma anche “Emmanuele”, Dio-con-noi, chino sulla sua creazione e sull’umanità. Egli, come dirà l’Apocalisse, è «Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente» (1,8), capace di abbracciare e superare il tempo e lo spazio perché eterno e infinito, eppure pronto a camminare accanto alla sua creatura, a guidarla, a sollevarla, a redimerla. In questa formula, allora, s’intrecciano il mistero e la rivelazione di Dio oppure, per usare il linguaggio dei teologi, la trascendenza e l’immanenza. Come cantava un grande poeta, Rainer Maria Rilke, «l’Inconoscibile si erge accanto a noi silenzioso ma salvatore».
Il Gesù del quarto Vangelo assumerà questa formula mirabile applicandola a se stesso e suscitando lo scandalo dei suoi interlocutori: «In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono» (Giovanni 8, 58). E la nostra reazione potrebbe essere quella del grande filosofo e scienziato Blaise Pascal nel testo che egli portava sempre con sé: «Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi, dei dotti. Certezza. Sentimento. Gioia. Pace. Dio di Gesù Cristo. Dio mio e Dio vostro… Egli non si trova che nelle vie indicate dal Vangelo».