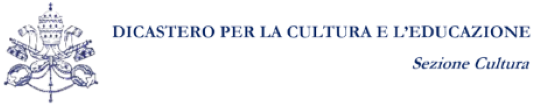LA VITA NUOVA ED ETERNA
Il Re dell’universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. (2 Maccabei 7,9)
«Ognuno vive dentro ai suoi egoismi, / vestiti di sofismi, / e ognuno costruisce il suo sistema di piccoli rancori irrazionali, / di cosmi personali, / scordando che poi infine tutti avremo / due metri di terreno». Queste parole della Canzone di notte n.2 del cantautore modenese Francesco Guccini hanno una loro potenza malinconica e severa che potrebbe rimandare a una parabola di Gesù narrata dall’evangelista Luca: essa ha al centro un riccone insensato che accumula senza posa, ma nel silenzio notturno sente una voce gelida e inesorabile: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai accumulato di chi sarà?» (12,20).
Tuttavia c’è, nella visione religiosa, un “oltre”, come diceva una grande poetessa americana, Emily Dickinson: «Questo mondo non è Conclusione. / Un seguito è al di là. / Fa segno e sfugge. / Filosofia non lo sa. / È l’Intuizione, alla fine, a penetrare l’Enigma». Ecco, l’Intuizione della fede ci svela l’Oltrevita. Ed è ciò che uno dei sette figli ebrei proclama, mentre sta per avviarsi al patibolo durante la dura repressione perpetrata dal re siro Antioco IV Epifane nel II secolo a. C. Ad essa reagirà la rivolta nazionale dei fratelli Maccabei, la cui epopea è celebrata appunto nei due libri omonimi della Bibbia, a cui abbiamo attinto il nostro frammento.
È una professione di fede, breve ed essenziale, che questo ragazzo eroico lancia al suo carnefice che lo sta «eliminando dalla vita presente». Una professione che verrà ribadita anche dagli altri fratelli, uno dopo l’altro, certi di «riavere di nuovo le membra» che stanno per essere dilaniate: «Da Dio si ha speranza di essere da lui di nuovo risuscitati» (7,11.14). Alla fine sarà la loro stessa madre a lasciare questo mirabile testamento: «Non so, o figli, come siete apparsi nel mio grembo; non sono stata io a darvi il respiro e la vita, né ho plasmato le membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore dell’universo, che ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita» (7, 22-23).
La fede nella risurrezione, la certezza che la vicenda umana non si conclude in quei «due metri di terreno», l’appello a guardare oltre la pala del becchino sono, quindi, presenti già nella speranza di Israele e brilleranno di luce vivida nella Pasqua cristiana. Questi ragazzi, comunque, attestano anche un altro aspetto: la fedeltà ai grandi valori della loro religione e della loro morale, che non tradiscono neppure di fronte alla minaccia di morte. Questa coscienza rende coraggioso e sereno anche il loro varcare la soglia estrema della vita terrena. «Il vero modo di tenersi pronti per il momento finale è quello di impiegare bene tutti gli altri momenti», ammoniva lo scrittore e vescovo francese del Seicento François Fénelon. E a lui farà eco tre secoli dopo il filosofo e psicoanalista tedesco Erich Fromm: «Morire è tremendo, ma l’idea di dover morire senza aver vissuto è insopportabile».
Quei giovani guardano in faccia la morte non solo perché sanno che essa non è l’approdo ultimo della loro esistenza, ma anche perché hanno tra le mani un tesoro che non si corrompe e che non è rapinato, un tesoro di amore, verità, giustizia. Sono realtà eterne, perché partecipano della stessa essenza di Dio che è amore, verità, giustizia, luce. Sono questi valori ad attirarci verso l’abbraccio eterno col Signore della vita.