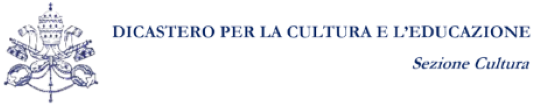SCANDALO E STOLTEZZA
I Giudei chiedono segni, i Greci cercano sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani. (1 Corinzi 1, 22-23)
Sul monte che domina l’attuale Corinto rimangono oggi solo tre possenti colonne doriche, unico resto del monumentale tempio di Afrodite, vero e proprio simbolo di una città allora splendida, dotata di due porti, con seicentomila abitanti. In quel tempio erano in attività ben mille “ierodule”, o prostitute sacre. L’idolatria e la corruzione erano, quindi, quasi l’emblema di Corinto al punto tale che “corintizzare” in greco era divenuto il verbo del vizio. San Paolo giunge in questo groviglio di varia umanità e di degenerazione, ma anche di splendore intellettuale e artistico (stupenda è la fontana Pirene, mirabile è il tempio di Apollo, ricca di monumenti l’agorà), nell’inverno 50-51, reduce dal fallimento della missione ad Atene, ove all’Areopago era stato sbeffeggiato al termine del suo intervento pubblico (Atti 17, 16-34).
Anni dopo, forse nel 55 o 57, egli indirizza alla comunità cristiana corinzia, inquinata dall’atmosfera pagana esteriore e divisa al suo interno, una Lettera di taglio pastorale che in apertura pone in modo icastico e luminoso la figura di Cristo. Essa brilla nella celebre dichiarazione che abbiamo sopra citato, divenendo come una discriminante o una linea di demarcazione tra due orizzonti culturali e religiosi diversi. Da un lato, c’è il giudaismo che fonda la sua religiosità sui “segni”, ossia sui prodigi, sul clamore di un Dio che deve entrare in scena in modo esplicito e trionfale, un po’ come era accaduto nell’epopea esodica della liberazione dall’oppressione faraonica in Egitto.
D’altro lato, c’è invece la sofisticata cultura greca che concepisce la fede come un sistema dottrinale, costruito su una argomentazione fatta di teoremi razionali, la “sapienza” appunto. Come si vede, in entrambe queste concezioni si è in cerca di sicurezze, di garanzie, di prove. Qual è la risposta cristiana? È nel paradosso della croce, anzi del Dio crocifisso, umiliato nella condanna capitale riservata ai terroristi e agli schiavi. Di fronte a questo vessillo di fede, scatta la reazione di “scandalo” del giudaismo, che “inciampa” (tale è in senso del vocabolo greco skándalon) in una simile concezione, e si ha il rigetto sarcastico del mondo greco che considera tale proposta una moría, ossia una “stoltezza”, un assurdo indegno dell’intelligenza.
Eppure san Paolo è convinto che proprio da questo apparente abisso della mente e delle attese umane può fiorire un segno glorioso di salvezza. Nel Cristo Crocifisso, infatti, si cela la divinità con la sua potenza e sapienza infinita. Ecco, allora, la conclusione dell’Apostolo che nella sua vita aveva sperimentato l’energia vitale e trasformatrice della croce di Cristo: «Per coloro che sono chiamati sia Giudei sia Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1,24-25).