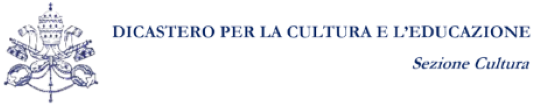Tra la curiosità dei passanti, in quel giorno di aprile forse dell’anno 30, avanzava un picchetto militare romano guidato da un centurione, l’exactor mortis, colui che avrebbe dovuto verificare l’avvenuta esecuzione capitale di quel condannato, il galileo Gesù di Nazaret, che trascinava a fatica sulle spalle il patibulum, ossia la trave trasversale che sarebbe stata imposta al palo verticale, già conficcato nel terreno del piccolo colle, il Golgota, in aramaico «cranio», in latino calvarium, luogo della crocifissione. Su quella scena potremmo far scorrere in sovrimpressione le emozionanti immagini del Cristo che porta la croce affaticandosi a procedere nella neve striata dal sangue che cola dalle ferite delle precedenti torture inflitte dai soldati romani, così come ce le ha proposte Andrej Tarkovskij nel suo mirabile film Andrej Rublëv (1966).
Alla fine lo spettacolo macabro, purtroppo sempre gradito a una piccola folla di sadici repressi, si conclude con la crocifissione e la relativa morte per soffocamento del condannato. Sull’asse verticale della croce, in una placca, è collocato il titulus, ossia il capo d’imputazione, scritto in latino, la lingua ufficiale, in greco, la lingua allora internazionale e nell’ebraico locale: «Gesù nazareno re dei Giudei», che diverrà nei secoli successivi l’acronimo INRI (Jesus Nazarenus Rex Iudeorum). Il Crocifisso, prima di spegnersi, emetterà sette ultime frasi che, secoli dopo, nella musica di Haydn diverranno un emozionante lamento universale, mentre per la fede dei cristiani saranno sempre l’estremo testamento del loro Dio che muore.
Nessuno in quel pomeriggio primaverile gerosolimitano – era l’ora nona, cioè le tre pomeridiane – avrebbe immaginato che quella scena tragica, non rara durante il ferreo regime del governatore imperiale della Palestina Ponzio Pilato, sarebbe divenuta un vessillo simbolico destinato ad attraversare i millenni. Quella croce si sarebbe trasformata per l’intera cultura occidentale in un «soggetto planetario». È questo il sottotitolo che uno dei maggiori storici dell’arte cristiana contemporanei, il francese François Boespflug, ha imposto a un suo imponente «catalogo» emblematico delle raffigurazioni della Crocifissione.
In una sfilata impressionante di immagini, accompagnate da schede che spesso sono simili a narrazioni, si affacciano le più celebri e le più modeste, le più antiche e le più recenti rappresentazioni artistiche di questo evento capitale della storia umana. È impossibile anche soltanto selezionare in questa mappa sterminata, eppur sempre originale, qualche soggetto: si pensi che soltanto a partire dal 1945 sono decine e decine le Crocifissioni che scorrono davanti al lettore di quest’opera, incrociando artisti del tutto inattesi, capaci di smentire la «vulgata» del divorzio tra arte e fede consumatosi nel ’900. Per non dire, poi, che lo sguardo di Boespflug si allarga fino all’Africa, all’Asia, all’America Latina e persino all’Australia e Oceania.
Se fossi sollecitato a optare almeno per un esempio, anche a costo di essere scontato, riproporrei il provocatorio e sconcertante «retablo di Isenheim», il polittico che Matthias Grünewald dipinse tra il 1512 e il 1514 e che è ora custodito nel Museo di Colmar in Alsazia. Descrivere quella scena è sminuirne la scandalosa brutalità coi rozzi tronchi di legno della croce, col corpo livido di Cristo, il suo torace gonfio, i piedi che si torcono, le dita che si protendono disperate, il capo piegato fino a spezzare il collo, sotto un cielo tenebroso… Ma la pubblicazione quasi contemporanea di un sorprendente piccolo saggio di un noto storico francese, Thierry Lentz, mi spinge a proporre un’altra esemplificazione.
Velásquez: i chiodi della Passione s’intitola questo libretto molto originale che è la narrazione storico-critica, estetica e teologica del pellegrinaggio al museo del Prado davanti a questo Crocifisso, un olio su tela del 1632, che questo studioso agnostico ha vissuto e che ripropone ai suoi lettori. Ne nasce il resoconto di un’esperienza esistenziale straordinaria in cui quell’uomo crocifisso – che emerge da uno sfondo totalmente buio, col suo corpo nudo dalla carne luminosa, quasi ritto e solenne su quella croce che diventa il suo trono (non per nulla una nube dorata avvolge il suo capo chinato) – interpella lo spettatore senza fissarlo negli occhi e senza interrogarlo direttamente. Boespflug nella scheda che dedica a questo quadro vi intuisce «un silenzio di morte; ma la serenità che ne emana dice già la vittoria sulla morte». E Lentz, a sua volta, conclude: «Diego Velásquez è riuscito a dipingere il silenzio». E confessa: «Ignoro perché, anche se sono passati milioni di visitatori transitando o fermandosi davanti a questa Crocifissione, ho avuto la sensazione strana che essa abbia “parlato” proprio a me».
Questo suo riconoscimento personale è fondato. Nella mia biblioteca centinaia sono i saggi e i trattati esegetici e teologici sulla passione e morte di Gesù, ma forse nessuno di essi sarebbe in grado di suscitare non dico in un agnostico ma anche in un credente un’emozione come questa. Aveva ragione un ateo dichiarato come Emile Cioran quando compativa i teologi che pure l’avevano assediato coi loro raffinati percorsi speculativi, perché non erano stati capaci di riconoscere un dato elementare: «Ogni volta che ascolto la Messa in si minore o la Passione secondo Matteo o una cantata di Bach devo confessare che Dio deve esistere ed è questa l’unica prova che i teologi hanno trascurato». Ma a questo punto non possiamo ignorare che i Vangeli non considerano la morte di Cristo sulla croce l’estuario definitivo di un’esistenza votata all’abisso del silenzio sepolcrale.
È così che, dopo le ore dell’agonia, la tenebra della morte e il grembo della tomba, sorge il sole dell’alba di Pasqua. È «il paradosso della Risurrezione», come s’intitola una raccolta di articoli teologici curati da Antonio Landi, da poco editi, ultimo anello di una catena bibliografica infinita. Qui, pur non abbandonando completamente il terreno della storia, ci inoltriamo verso altre frontiere, quelle della fede e dello spirito. E a guidarci là può essere ancora una volta l’arte che – come suggeriva Paul Klee – non s’accontenta del visibile ma rappresenta l’Invisibile che si cela nel visibile. È di nuovo François Boespflug, accompagnato anche questa volta da una studiosa italiana di iconografia bizantina, Emanuela Fogliadini, ad affacciarsi su questo tema più arduo, la Risurrezione di Cristo, con cui l’arte d’Oriente e d’Occidente si è confrontata.
Impresa non facile per gli artisti perché i Vangeli canonici tacciono sull’atto in sé del «risvegliarsi e innalzarsi» del Cristo dalla tomba (tale è il valore dei verbi greci usati), rimanendo sospesi tra il «prima» del sepolcro spalancato e il «poi» degli incontri o «apparizioni» del Risorto. A questo vuoto hanno supplito i Vangeli apocrifi ma soprattutto la creatività artistica. Ed eccoci, così, di fronte alle cinquanta rappresentazioni selezionate in questa sorta di album che parte da una delle più antiche rappresentazioni del Risorto seduto davanti alla propria tomba in un pannello d’avorio del Castello Sforzesco di Milano, per approdare a un acrilico su tela del giovane pittore croato Nikola Sarić (35 anni) con la sua Nuova creazione che vuole incarnare le parole del Cristo glorioso dell’Apocalisse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (21,5)
E se anche per la risurrezione di Cristo dovessimo optare in questa galleria straordinaria per un dipinto-vessillo, condivideremmo la scelta di copertina del volume di Boespflug-Fogliadini col possente e indimenticabile «Cristo che esce dal sepolcro», l’affresco che Piero della Francesca eseguì tra il 1463 e il 1465 per il Palazzo dei Conservatori della sua città, Sansepolcro, «il più bel dipinto del mondo», come l’aveva definito lo scrittore inglese Aldous Huxley.
GIANFRANCO RAVASI
François Boespflug, Crucifixion, avec le concours d’Emanuela Fogliadini, Bayard, Paris, pagg. 559, € 59,90.
Thierry Lentz, Velásquez: i chiodi della Passione, Salerno Editrice, Roma, pagg. 138, € 12,00.
François Boespflug – Emanuela Fogliadini, La Risurrezione di Cristo nell’arte d’Oriente e d’Occidente, Jaca Book, Milano, pagg. 221, € 70,00.
Si veda anche Antonio Landi (a cura di), Il Paradosso della Risurrezione, Dehoniane, Bologna, pagg. 155, € 19,00.
(Pubblicato su IlSole24ORE (05/04/2020).