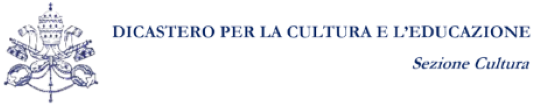«Grande tra gli uomini e di gran terrore è la potenza del riso: contro il quale nessuno si trova difeso da ogni parte. Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo». Può essere per molti una sorpresa sapere che questo aforisma è nato dalla penna di un autore che siamo soliti immaginare intristito e pessimista: è, infatti, il n. 78 dei Pensieri di Leopardi. Il vero riso svela il lato positivo della realtà, aiuta a vivere anche le esperienze più ardue, ha effetti anche fisiologici («il riso fa buon sangue», dice la sapienza popolare) e riesce spesso a demolire le ipocrisie, mostrando che «il re è nudo», nonostante la propaganda. L’ironia è segno di libertà, di intelligenza e di creatività. È per questo che imponente è la bibliografia dedicata a questo atto umano, sia a livello strettamente letterario («È meglio scrivere di riso che di lacrime, perché il riso è segno dell’uomo», osservava Rabelais ovviamente nel suo esilarante eppur profondo Gargantua e Pantagruel), sia in sede filosofica (Kierkegaard insegna) o teologica (ad esempio, il serioso Karl Rahner e suo fratello Hugo, autore di un saggio dal titolo emblematico, Homo ludens).
Certo, come ogni virtù può degenerare in vizio (la sessualità in lussuria, tanto per esemplificare), così anche il riso può precipitare nel sarcasmo aggressivo, nell’insulto truce, nella sguaiatezza volgare, come attesta in modo folgorante quello che corre sui viali della rete dei social. Tuttavia il riso primigenio, insegna dell’umano (la iena ridens è solo un antropomorfismo), può essere persino un’analogia divina. È ciò che vuole insegnare il gesuita americano James Martin che, oltre ad aver spesso cosparso i suoi libri con la spezia dell’ironia (come nella sua Guida del gesuita… a quasi tutto, tradotta dalla San Paolo nel 2017), si consacra ora all’impresa di dimostrare «perché gioia, umorismo e riso sono al centro della vita spirituale».
Lo fa in un volume – così scoppiettante che è difficile delinearne la trama e, quindi, recensirlo in modo coerente – posto all’insegna della certezza che Anche Dio ride, come recita il titolo. Lo stile “americano” rende le sue pagine un ininterrotto intarsio di battute, di aneddoti, parabole, provocazioni, consigli, tutti ibridati dal sorriso, dall’ironia, dallo scherzo, senza però decadere nello sghignazzo o nel motto caustico e derisorio. E questo perché il suo programma è quello di affermare che la vera spiritualità non è in un viso macerato, fosco e lamentoso, bensì nella gioia serena di chi è in pace con se stesso, con Dio e col mondo, tant’è vero che il suo monito ideale è questo: «Tieniti stretta la tua gioia come faresti con la tua fede in Dio».
La tesi si sviluppa in tante ramificazioni, svincolate dalla convinzione che ascesi e tristezza siano sorelle e che religione e penitenza siano tra loro esclusive compagne di viaggio, così da accedere alla gioia come «segno eloquente» della spiritualità autentica. In questo percorso, secondo Martin, l’umorismo è coniugato con la santità, la felicità del credente è attrattiva e coinvolgente più di una rigorosa argomentazione apologetica, la lievità (che non è banalità) rende calda l’atmosfera ecclesiale, liberata dalla gelida querimonia moralistica, il piacere non diventa automaticamente sinonimo di vizio, le domande più laceranti possono essere liberate da alcune spine, la preghiera non si riduce solo a supplica, ma conosce anche il canto innico.
Come si diceva, queste componenti sono affidate non tanto a riflessioni sistematiche ma alla forza pirotecnica della narrazione e al ricamo delle intuizioni come fa il giocoliere con l’arabesco delle palle in movimento, senza temere che i benpensanti ripetano contro i cristiani quell’accusa beffarda scagliata contro Gesù: «È un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori» (Matteo 11,19). Effettivamente il rabbì di Nazaret amava i banchetti e detestava gli ipocriti che «quando digiunano diventano malinconici e assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano» (Matteo 6,16). Si conferma, così, quanto fosse riduttivo e fin fazioso il detto medievale attribuito falsamente a sant’Ambrogio secondo il quale nei Vangeli flevisse lego, risisse numquam, cioè che in essi si legge che Cristo abbia soltanto pianto, ma mai abbia riso.
Il rimando alla vita spirituale che p. Martin, «il gesuita oggi più noto al mondo dopo papa Francesco», come si è detto di lui con evidente eccesso (forse a causa anche del suo particolare ma non eterodosso approccio alla morale sessuale), ci spinge a evocare una recente «storia della spiritualità cristiana», rubricata nel titolo sotto il termine tipico evangelico del discepolato, Alla sequela di Gesù. Autore è Christoph Benke, un sacerdote austriaco, coi titoli accademici giusti, ma impegnato anche nella pastorale parrocchiale ordinaria. Non molti sanno che il celebre Vade retro, Satana, rivolto da Gesù a un Pietro un po’ ottuso, non è un esorcismo contro un tentatore, bensì un invito a «mettersi in cammino dietro» il Maestro, seguendone (la «sequela») le orme, anche quando s’inerpicano sull’erta scoscesa e pietrosa del Calvario, senza lasciarsi tentare dallo scoramento diabolico.
La trama storica del volume è scandita dalla diacronia, ritmata a sua volta su un pentagramma che non è solo cronologico. Infatti il tempo della Chiesa antica, che comprende la scelta radicale del martirio o quella aspra dell’ascesi e affascinante del monachesimo, si differenzia dal Medioevo che apre nuove vie anche per i laici, si erge sui picchi della mistica, si spoglia delle ricchezze nell’imitazione del Cristo povero secondo lo stile di san Francesco. È, invece, Lutero nell’età moderna a spostare l’asse sul primato assoluto di Dio che ha un contrappunto nel «reclamare il mondo per Dio» operato da Ignazio di Loyola, mentre il linguaggio dell’amore irrompe, prima, con Teresa d’Avila e, poi, con Francesco di Sales.
Si apre, così, la modernità con un ricco arcobaleno di esperienze dai colori squillanti, coi nomi – tanto per citare i più famosi – di Kierkegaard, Teresa di Lisieux, Bonhoeffer e persino di un generoso Segretario Generale dell’ONU, Dag Hammarskjöld, per non parlare di Simone Weil. Curiosamente Benke fa salire sulla ribalta anche p. Paolo Dall’Oglio, il noto gesuita dal 2013 considerato disperso a Raqqa in Siria, con la sua proposta della sequela di Cristo nella «chiesa dell’Islam». Chiesa antica, Medioevo, Età moderna, modernità-contemporaneità convergono verso l’ultimo quadro, il quinto del pentagramma: è quel «presente» sbocciato dal Concilio Vaticano II e fiorito in un «ventaglio di stili» che permettono uno sguardo finale panoramico.
Quello disegnato da Benke è, quindi, un affresco ove la spiritualità s’intreccia con la storia e la cultura. Si riesce, così, a capire perché un agnostico radicale come Bertrand Russell abbia scritto un saggio sul Misticismo e la logica, riconoscendo che «i più grandi filosofi hanno sentito il bisogno sia della scienza sia della mistica… che è un’intensità e profondità di sentimento riguardo a tutto ciò che si concepisce a proposito dell’universo».
GIANFRANCO RAVASI
James Martin, Anche Dio ride, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), pagg. 314, € 25,00.
Christoph Benke, Alla sequela di Gesù, Queriniana, Brescia, pagg. 286, € 30,00.
Pubblicato col titolo: Il bello di farsi due sante risate, su IlSole24ORE, n. 74 (15/03/2020).